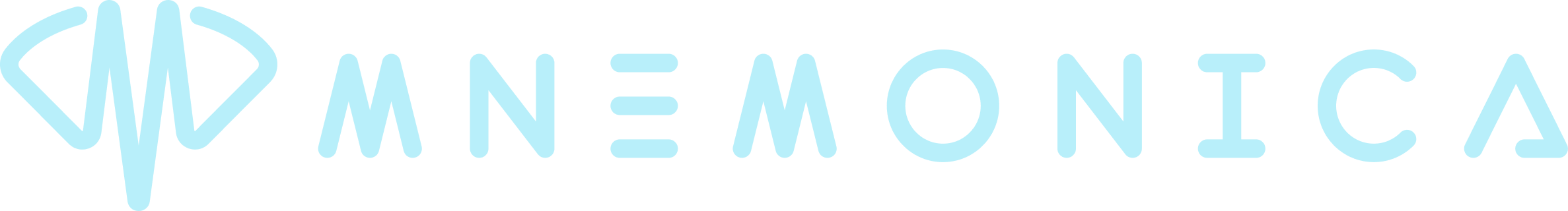31 Jan Aristotle vs. Flat Indexing: Why We Chose Tags Instead Of Directories
Posted at 13:50h
in
articles
by Stefano Diana
The search for order has always been a human necessity. Only that which is regularly repeated makes it possible to predict a modicum of the future and loosens the perennial grip of chance. Laws of nature discovered through the scientific method are essentially recurring phenomena. Truth itself, according to Simon Baron-Cohen, is for us humans just something that repeats itself. As a neuropsychologist with expertise in autism, he has studied extensively the human types most capable of recognizing patterns and repetition around themselves. He identified the so-called “hyper-systemizers” in whose ranks we find the great scientists, inventors, mathematicians, and artists.
The origin of our method of organizing the world can be traced back to the first outstanding example of a hyper-systemizer and pattern-seeker in our history: Aristotle. His “categories” –substance, quantity, quality, relation, etc. – were the primary and supreme characters of everything, like a set of coordinates that taking specific values for each thing identified its place in the universal order. Categories aimed at sorting all that exists, and also at describing evolution by their variations.Aristotle’s aspiration for universal ordering never died, and his systematics has always found new adherents to renew its fire. In general, it proved to be beyond human capacity: in the nuanced and complex realm of everyday experience, Aristotelian universals were helpless, and every supposed rule faces innumerable possible exceptions. Wittgenstein softened their claims by reducing them to a simple “family feel,” a similarity between phenomena that can be guessed but not precisely described.
However, the method has been successfully applied in confined areas. In the modern era, all academic disciplines have produced their ontologies, that is, their particular “sciences of being” made up of categories, to structure knowledge and narrow complexity. A famous example is the taxonomy that Charles Linnaeus established in the natural sciences in the 1700s, starting with the genus + specific difference pair prescribed by Aristotle in Metaphysics. Linnaeus extended this basic hierarchy to increasingly refined levels that could encase all known living things. Being open-ended, it was modified and expanded over time and despite the centuries has remained a fundamental tool for organizing scientific knowledge.
Taxonomy has also been used effectively for cultural artifacts. For example, documents, the subject of archivistics. Which became a science in its own right in the 16th century, detaching from paleography and diplomatics to devote itself to the preservation of memory. The culmination of its efforts is the 1994 General International Standard Archival Description or ISAD(G), which defines the descriptors needed to organize and identify documents of all kinds in a consistent and comprehensive manner. Here, too, the descriptors are structured in hierarchical levels and proceed from the general to the particular.
Another notable case is books. In libraries at the beginning of the modern era, different institutions used different cataloging schemes: for example, at La Sorbonne in Paris, books were sorted first by subject, and then alphabetically. In the late 18th century came the invention of card catalogs: each card is a bibliographic record that virtually represents a particular physical work by means of a fixed set of data such as author, title, etc., called index terms (we will return to this later).
Conceptually, the card is a great step forward to our time: if you think about it, in fact, the resource descriptors contained in the card are nothing more than metadata. The transition to computational systems in fact keeps within the tradition, as far as knowledge organization is concerned: its computer version is a construct extremely familiar to all of us, the file system. The file system is the operating system component that segments an immense and indistinct mass of bits, assigning a name and certain properties – metadata, in fact – to each significant portion. Not surprisingly, the term “file” is the same one that was used for paper catalogs: clear evidence of the total conceptual continuity between analog and digital archiving. The continuity is also found in the information architecture: among the principles and devices inaugurated by the Multics operating system in 1964, which set the standard, is the hierarchical file system with the common directory tree.
Even the idea of the information layer superimposed on the physical world, which was already in bibliographic cards, is taken up and enhanced in computational systems to reduce inhuman complexity. What the user sees is decoupled from what the machine sees. «The basic structure of the file system is independent of machine considerations. Within a hierarchy of files, the user is aware only of symbolic addresses. All physical addressing of a multilevel complex of secondary storage devices is done by the file system, and is not seen by the user. (…) In general, a user will not know how or on what device a file is stored.»[1] This trick will also serve to present the user with a virtual memory space larger than the physical one, and allow programs to run that would not fit in the physical one, using a swap file.
Such tricks were repeated and extended by Ken Thompson from the earliest versions of Unix, where we find the mature version of the hierarchical file system as a tree of arbitrary depth. In Multics, directories were also “files”; in Unix this generalized file concept is extended to the device abstraction. In the new interpretation, directories are virtual containers that list only the names of files with their pointers to so-called inodes, which in turn contain file attributes and the addresses of the memory blocks where the data are located. Unix completely decoupled hierarchy information from file access information, and needed a numeric index to go from one to the other in the access table: hence the name i-node, short for index node.With this comes the possibility of having multiple filenames in different directories pointing to the same data, and the file system is able to map graphs onto the tree. Probably the innovation reflects the fact that the simple tree structure was already too tight, and the need was felt to multiply the ways of relating files to one another. Since the logical structure of files is machine-agnostic, how to organize them becomes a free choice of the designers.
Like programming languages, the logical interface layer has been refining and expanding abstraction capabilities more and more as processing power has grown. Whereas twenty years ago a single, coherent object could be in fact scattered in a lot of small data chunks on a disk, perhaps to optimize space or read/write operations, in today’s cloud infrastructures we can see as a single object what is distributed across many hosts on different continents. We can also run many virtual machines on the same physical system, and even virtualize operating systems themselves by running small parts of them in separate containers.
The current deluge of information, in which search engines are our indispensable guide, reminds us that the inseparable companion of preservation is information retrieval. What is archived should be retrievable and exhumed with reasonable ease, and for this to happen, techniques are needed that take into account both what ‘information looks like and the cognitive and psychological capacities of the humans who need it. The aforementioned ISAD(G) archival standard, for example, avowedly aims to «identify and illustrate the context and content of archival records in order to promote their accessibility», to foster the «intellectual control necessary to ensure that reliable, authentic, and meaningful descriptive records are transmitted over time», and to facilitate «the retrieval and exchange of information (…) in a unified information system».
Essential in information retrieval are indexes, what we have seen above as index terms in cards and as index nodes in Unix. In general, indexes are signs that, precisely, indicate other things. In C. S. Peirce’s semiotics they link signifier and signified in a relation of contiguity, especially of cause-and-effect: the footprints of an animal and the presence of the animal, smoke and fire. Thus the set of index terms that make up a bibliographic record stand for a particular book in the library. The index terms of the cards all together form the dictionary of bibliographic records, in practice they are the Aristotelian categories of that world: the parameters necessary and sufficient to catalog the universe of books in a physical library so that they can be found at a glance.
Those who used the first popular search engine, Altavista, in 1995 will remember that it kept a list of thematic directories on the left column: these were clear vestiges of the old cataloging method, which in that remote era was still thought to be enforceable on a Web made up of a handful of sites – only 23,500 according to NetCraft and Internet Live Stats’ estimate. The distance between Altavista’s homepage and the minimalism of today’s Google homepage tells better than any words the radical transformation that information retrieval has undergone: only one field for user input has survived. Because there are now some 2 billion sites out there, index terms are more than the stars in the sky, and the only thing that makes sense is to give users carte blanche. This freedom is assisted by suggestions that are also statistically derived from users’ search keys.
Top-down categories were already being challenged on another front: the new wave of the Web that arose in the early 2000s. The lazy interactivity of Web pages received a dizzying momentum thanks to UI innovations such as Asynchronous Javascript And XML (AJAX), and the user began to materialize as an active producer of choices, content, and conversations. It is the birth of what Tim O’Reilly christens Web 2.0, characterized more than anything else by the ubiquitous share button, and the tide of User-Generated Content starts to swell the Web unabashedly.
Grassroots mass participation makes entirely new stuff possible, in which the collective drive of distant and unknown people can be synchronized upon a single online goal and concretize into extraordinary results in terms of numbers. These are numbers of unprecedented magnitudes, these are the new mass phenomena to which we are accustomed today: for example, the many kinds of crowdsourcing, or the viral effect that can quickly take egregious strangers from oblivion to millions of ratings in a very short time. And the immense, atomized, talkative crowds of this superconductive global society are more impervious than ever to the old top-down methods of cataloging. So many people are interacting that it is impossible for any authority to claim exhaustive, universal ways of reading and sorting the world (except, of course, for Big Tech imposing their own categories through platform software).
Therefore bottom-up, user-chosen categories are born: tags. Aristotle must have turned in his grave to see ordinary people decide on favorite keywords to stick to their digital assets, to organize them, explore them, and retrieve them in their own ways. The idiosyncratic order of one’s bedroom extends to the entire Web 2.0. With tags, taxonomies are replaced by folksonomies: classification systems, as the composition of the neologism suggests, that put the spontaneity of the folk, the popular as opposed to the authoritative, the common sense of the people, in place of prefixed hierarchical taxa.
What is really new and remarkable is that tags are horizontally visible between users, link to each other and overlap, giving rise to unprecedented phenomena. For example, the miracles that Photosynth has been doing for a few years since 2008. It was a collaborative platform, now sadly gone, where anyone could upload travel photos with their good tags. Then an image-processing technology from Microsoft Research, most advanced for the time, would combine them based on their tags. It could recognize the commonalities between the scenes portrayed, taking into account different perspectives, and thereby calculate the three-dimensional scenery of which they were part. Stunning pointclouds, swarms of bright points that formed the 3D gestalt of a panorama or building, such as San Marco’s Basilica in Venice, were found on the site. These 3D models were navigable in the browser.
Even more remarkably, one could switch at any time from pointcloud divisionism to photographic visualization, to explore the location through its primary constituents: thousands of photos tagged “San Marco” or something. The synths showed photos in the right perspective relative to the current viewpoint in the browser. It was a truly unique intermedial experience. And a socio-technical experiment, too, considering that so many people had taken those shots in their own travels, never imagining they were building a collaborative work.
This collective horizon was already in the very first user-defined-tags-based service I remember using: the handy del.icio.us social bookmarking service, founded in 2003. Saving the most interesting sites in my online profile instead of the solitude of my browser, browsing other people’s tags and so discovering other worlds, was my first real experience of immediate horizontal expansion of knowledge, typical of the information society. What now, never meeting any resistance, has slipped into our normal information overload disorientation, a constant veil of nausea and performance anxiety.
User-defined tags have proven to be the index terms best suited to the global network information ecosystem, malleable enough to adapt to the enormous variety of sources and usage practices encountered around the world. It is the victory of the particular over the Aristotelian universal. By linking together, tags can compose frames of great complexity, which at large scales are spontaneously structured by the statistical properties of the whole. However, even in local contexts, their nonhierarchical modularity allows for the creation of graphs of interest, for example, operating on idiomatic dictionaries specific to a field of knowledge or work.
This is why in Mnemonica we adopted tags instead of the hierarchical file system when faced with the main design choice: how to organize uploaded content. In media asset management platforms of the audiovisual industry, they usually follow the classic file system scheme for organizing clips: a project contains folders, each folder houses content, on each folder you can do certain operations (e.g., sending to a set of recipients), on the contained files you can do other operations. These platforms are inspired by a principle of habit: because the hierarchical file system is so absolutely commonplace for everyone, it is what everyone expects to find in a file management interface, and everyone knows how to use it without instructions.
But even here the universal does not necessarily go along with the particular. Was the directory tree the most appropriate information structure for people working in film production, considering their specific workflows, the rapid times with which they have to access content, the kind of data they generate, the order in which they do so and then return to consult it, the way they interact with one another, and so on? Our answer was no. To us the hierarchical file system, as indeed the folder itself, seemed archaic and too rigid compared to the day-to-day needs of cloud cinema. That fluid method of work following a plan but continually adapting to circumstances deserved to be indulged by an equally flexible scaffold. And the perfect joint to build it was the tag.
So we designed our flat indexing, which enables some very special features of Mnemonica.
How does it work? For starters, the media are housed in Screening Rooms that are not folders but controlled social viewing spaces made specifically for the requirements of film/TV production. They are also active environments, in the sense that they are also capable of automatically processing their content, e.g. applying watermarks or distributing content to many separate audiences at different times.
Then in the Screening Rooms we have Days and Bins, which look like containers or folders but are neither. Both Days, corresponding to days in the production plan, and Bins, multi-purpose containers that can be used, for example, as scenes or as casting roles or locations, are actually tags associated with media. Other tags can be related to these as desired, while Bins can be associated with both generic tags and semantically marked tags such as location and character.
The simplicity with which they accomplish information retrieval, precisely because of the underlying tag structure, is truly unique. And here we should note something en passant: when people believe that the file system is the best thing because it can be used out-of-the-box, with nothing to learn, they forget that there is another case where the manual is not needed—when things are self-explanatory as you use them. That’s what happens in Memonica: when you tap on a Day and see it light up and at the same time see both the media pool and the Bin list next to it shrink, and then tap it again and see everything roll back, you instantly realize that that a Day works as a filter that selects in the media pool only the clips it contains. As anticipated, however, “contains” is just a convenient metaphor that aids UI learning: the real action of a Day is to select a tag over a set of media.
The same is true for Bins, whose behavior is equivalent. And even this very useful symmetry is possible only because Days and Bins are media tags and are not nested hierarchically, which would limit the possibilities. They are peer entities, connected through media. So to make a playlist I can select any Day first, and then one of the scenes shot on that Day; or, conversely, I can select any scene first, and then one of the Days on which it was shot. This effective immediacy is extended and further enhanced by the combined system of all the other tags that users can define in Mnemonica, and which are all filterable via the search fields scattered throughout the UI.
In our opinion, and according to our users nonetheless, this is the kind of elasticity in sorting content that best suits film people. Because #welovefilmmakers more than Aristotle did.
VERSIONE ITALIANA
La ricerca dell’ordine è da sempre una necessità umana. Solo ciò che si ripete regolarmente permette di prevedere un minimo di futuro, e allenta la morsa del perenne abbraccio del caso. Le leggi di natura scoperte dal metodo scientifico sono essenzialmente fenomeni che si ripetono. La verità stessa, secondo Simon Baron-Cohen, è per noi umani qualcosa che si ripete. Come neuropsicologo esperto di autismo ha studiato a fondo i tipi umani più capaci di riconoscere gli schemi e le ripetizioni intorno a sé, e ha identificato i cosiddetti hyper-systemizer nelle cui schiere troviamo i grandi scienziati, inventori, matematici, artisti.
L’origine del nostro metodo di organizzazione del mondo si può far risalire al primo esempio eccellente di hyper-systemizer e cercatore di schemi della nostra storia: Aristotele. Le sue “categorie” – sostanza, quantità, qualità, relazione, ecc. – erano i caratteri primari e supremi di tutto, come un insieme di coordinate che prendendo valori specifici per ogni cosa identificavano il suo posto nell’ordine universale. Le categorie dovevano permettere di catalogare tutto ciò che esiste, e anche di descriverne il divenire con le loro variazioni.
L’aspirazione di Aristotele all’ordinamento universale non è mai morta e la sua sistematica ha trovato sempre nuovi adepti a rinnovarne il fuoco. In generale si dimostrò al di sopra delle capacità umane: nel reame sfumato e complesso della esperienza quotidiana, gli universali aristotelici erano impotenti e ogni presunta regola si trova di fronte a innumerevoli eccezioni possibili. Wittgenstein ne addolcì le pretese riducendoli a una semplice “aria di famiglia”, una somiglianza tra i fenomeni che si può intuire ma non descrivere con precision.
Tuttavia il metodo è stato applicato con successo in ambiti circoscritti. Nell’era moderna tutte le discipline accademiche hanno prodotto le loro ontologie, cioè le loro particolari “scienze dell’essere” fatte di categorie, per strutturare la conoscenza e per limitare la complessità. Famoso esempio è la tassonomia che Carlo Linneo istituì nel ‘700 nelle scienze naturali, a partire dalla coppia <genere, differenza specifica> prescritta da Aristotele nella Metafisica. Linneo estese questa gerarchia a livelli sempre più raffinati per incasellare tutti i viventi conosciuti. Essendo aperta, si è potuta modificare e ampliare nel corso del tempo e nonostante i secoli è rimasto un fondamentale strumento di organizzazione della conoscenza scientific.
La tassonomia è stata adoperata efficacemente anche per gli artefatti culturali. Ad esempio i documenti, oggetto dell’archivistica. Questa diventa una scienza a sé nel XVI secolo, distaccandosi da paleografia e diplomatica, per dedicarsi alla conservazione della memoria. Il culmine dei suoi sforzi è la General International Standard Archival Description o ISAD(G), del 1994, che definisce i descrittori necessari a organizzare e individuare in modo coerente e completo documenti di qualsiasi tipo. Anche qui i descrittori sono strutturati in livelli gerarchici e procedono dal generale al particolare.
Un altro caso notevole sono i libri. Nelle biblioteche all’inizio dell’epoca moderna le diverse istituzioni usavano diversi schemi di catalogazione: ad esempio alla Sorbona di Parigi i libri erano ordinati prima per argomento, e poi alfabeticamente. Alla fine del XVIII secolo arriva l’invenzione dei cataloghi a card: ciascuna card è un record bibliografico che rappresenta virtualmente una determinata opera fisica mediante un insieme fisso di dati come autore, titolo, ecc., detti index terms (ci ritorneremo più avanti).
Concettualmente la card è un grande passo in avanti verso la nostra epoca: se ci pensate, infatti, i descrittori della risorsa contenuti nella card non sono altro che metadati. La transizione ai sistemi computazionali infatti si mantiene nella tradizione, in quanto a organizzazione della conoscenza: la sua versione informatica è quel costrutto estremamente familiare a tutti noi che è il file system. Il file system è il componente del sistema operativo che segmenta una immane e indistinta massa di bit, assegnando un nome e certe proprietà – metadati, appunto – a ogni sua porzione significativa. Non a caso il termine “file” è lo stesso che veniva usato per i cataloghi cartacei: chiara dimostrazione della totale continuità concettuale tra l’archiviazione analogica e quella digitale. La continuità si ritrova anche nell’architettura dell’informazione: fra i princìpi e gli accorgimenti inaugurati dal sistema operativo Multics nel 1964, che faranno scuola e saranno più o meno fedelmente adottati in tutti i sistemi operativi successivi, c’è il file system gerarchico col consueto albero di directory.
Anche l’idea del layer informativo sovrapposto al mondo fisico, che era già nelle card bibliografiche, viene ripresa e anabolizzata nei sistemi computazionali per ridurre una complessità disumana. Ciò che vede l’utente viene disaccoppiato da ciò che vede la macchina. «La struttura di base del file system è indipendente da questioni legate alla macchina. Nell’ambito di una gerarchia di file, l’utente è a conoscenza solo di indirizzi simbolici. Tutti gli indirizzi fisici di un insieme di dispositivi di memorizzazione secondaria a più livelli sono gestiti dal file system e non sono visibili all’utente. (…) In generale, l’utente non sa come o su quale dispositivo è memorizzato un file.»[1] Questo trucco servirà anche a presentare all’utente uno spazio di memoria virtuale più grande di quella fisica, e permettere l’esecuzione di programmi che non entrerebbero in quella fisica, usando uno swap file.
Tali artifici furono riproposti e ampliati da Ken Thompson sin dalle prime versioni di Unix, dove troviamo la versione matura del file system gerarchico come albero di profondità arbitraria. In Multics anche le directory erano “file”; in Unix questo concetto di file generalizzato si estende all’astrazione dei device. Nella nuova interpretazione, le directory sono contenitori virtuali che elencano solo i nomi dei file con i relativi puntatori ai cosiddetti inodes, che a loro volta contengono gli attributi del file e gli indirizzi dei blocchi di memoria dove si trovano i dati. Unix disaccoppiava completamente le informazioni sulla gerarchia da quelle di accesso ai file, e aveva bisogno di un indice numerico per passare dall’una all’altro nella tabella di accesso: di qui il nome i-node, short for index node.
Con ciò nasce la possibilità di avere più nomi file in directory diverse che puntano agli stessi dati, e il file system è in grado di mappare dei grafi sull’albero. Probabilmente l’innovazione rispecchia il fatto che la semplice struttura ad albero cominciasse già a stare stretta, e che fosse avvertita la necessità di moltiplicare i modi di mettere i file in relazione fra loro. Essendo machine-agnostic la struttura logica dei file, come organizzarla diventa una libera scelta dei progettisti.
Come i linguaggi di programmazione, il livello logico d’interfaccia è andato raffinando e ampliando le capacità di astrazione a mano a mano che la potenza di elaborazione cresceva. Se vent’anni fa poteva mostrare come un oggetto unico e coerente dei dati che di fatto erano sparpagliati in piccoli chunks su un disco, magari per ottimizzare lo spazio o le operazioni read/write, nelle infrastrutture cloud odierne possiamo vedere come un oggetto unico ciò che è distribuito su molti host in continenti diversi, possiamo far girare molte macchine virtuali su uno stesso sistema fisico, e perfino virtualizzare i sistemi operativi stessi eseguendone piccole parti in container separati.
Il diluvio di informazione attuale, in cui i motori di ricerca sono la nostra indispensabile guida, ci ricorda che l’inseparabile compagno della conservazione è il recupero dell’informazione. Ciò che viene archiviato si deve poter ritrovare e riesumare con ragionevole facilità, e perché questo accada sono necessarie tecniche che tengano conto sia di come è fatta l’informazione sia delle capacità cognitive e psicologiche degli esseri umani che ne hanno bisogno. Il citato standard archivistico ISAD(G) ad esempio si propone dichiaratamente di «identificare ed illustrare il contesto e il contenuto della documentazione archivistica per promuoverne l’accessibilità̀», di favorire il «controllo intellettuale, necessario per far sì che documenti descrittivi affidabili, autentici e significativi siano trasmessi nel tempo», e di facilitare «il recupero e lo scambio di informazioni (…) in un sistema informativo unificato».
Nel recupero dell’informazione sono essenziali gli indici, quelli che abbiamo visto nelle card come index terms e in Unix come index nodes. In generale gli indici sono segni che, appunto, indicano altre cose. Nella semiotica di Peirce legano significante e significato in una relazione di contiguità, specialmente di causa-effetto: le orme di un animale e la presenza dell’animale, il fumo e il fuoco. Così l’insieme degli index terms che compongono un record bibliografico indica un determinato libro nella biblioteca. Gli index terms delle card formano il dizionario dei record bibliografici: in pratica sono le “categorie aristoteliche” di quel mondo, i parametri necessari e sufficienti a catalogare l’universo dei libri di una biblioteca fisica in modo da ritrovarli a colpo sicuro.
Chi ha usato nel 1995 il primo search engine popolare, Altavista, ricorderà che conservava sulla colonna sinistra un elenco di directory tematiche: erano chiare vestigia del vecchio metodo di catalogazione, che in quell’era già remota si pensava ancora di poter imporre in un web fatto da una manciata di siti – 23.500 secondo la stima di NetCraft and Internet Live Stats. La distanza tra la homepage di Altavista e il minimalismo della homepage odierna di Google racconta meglio di qualunque parola la trasformazione radicale che ha subito l’information retrieval: è sopravvissuto solo un campo per l’input utente, dato che ormai i siti sono circa 2 miliardi, gli index terms sono più delle stelle in cielo, e l’unica cosa sensata è dare carta bianca. Questa libertà è assistita da suggerimenti che derivano anch’essi dalla statistica dalle chiavi di ricerca degli utenti.
Le categorie top-down erano già state messe in discussione su un altro fronte: la new wave del web sorta all’inizio degli anni 2000. La pigra interattività delle pagine web riceve uno slancio vertiginoso grazie a innovazioni nella UI come Asynchronous Javascript And XML (AJAX), e comincia a materializzarsi l’utente come produttore attivo di scelte, input, contenuti, scambi, conversazioni. È la nascita di quello che Tim O’Reilly battezza Web 2.0, caratterizzato più di ogni altra cosa dall’onnipresente pulsante “share”, e la marea degli user generated content inizia ad ingrossare la rete senza freni.
La partecipazione di massa dal basso rende possibili fenomeni del tutto nuovi, in cui la spinta collettiva di persone distanti e sconosciute si può sincronizzare su un unico obiettivo online e concretizzare in risultati straordinari dal punto di vista dei numeri. Sono numeri di grandezze mai viste prima, sono i nuovi fenomeni di massa ai quali siamo abituati oggi: ad esempio i tanti tipi di crowdsourcing, o l’effetto virale che può portare rapidamente degli egregi sconosciuti dall’oblio a milioni di visualizzazioni o ascolti in brevissimo tempo. E le folle immense, atomizzate e loquaci di questa società globale superconduttiva sono più che mai impermeabili ai vecchi metodi di catalogazione top-down. Le persone sono così tante, a interagire, che per un’autorità è impossibile pretendere di impostare dei modi esaustivi e universali di leggere il mondo e ordinarlo (fatta eccezione per i proprietari delle piattaforme che impongono i loro parametri, ovviamente).
Così nascono le categorie bottom-up, scelte dagli utenti: i tag. Aristotele si sarà rivoltato nella tomba a vedere persone qualunque decidere le keyword preferite da associare ai propri beni digitali, per organizzarli, esplorarli e ritrovarli a loro modo. L’ordine idiosincratico della propria camera da letto si estende all’intero Web 2.0. Con i tag le tassonomie sono rimpiazzate dalle folksonomy: sistemi di classificazione, come suggerisce la composizione del neologismo, che al posto dei taxa gerarchici prefissati mettono la spontaneità del folk, il popolare opposto all’autoritativo, il senso comune della gente.
L’aspetto davvero nuovo e notevole è che i tag sono visibili orizzontalmente fra utenti, si collegano fra loro con link, si sovrappongono, e dànno vita a fenomeni inauditi. Ad esempio i miracoli che fa Photosynth per qualche anno dal 2008. Era una piattaforma collaborativa, oggi purtroppo scomparsa, in cui chiunque poteva caricare le foto di viaggio con i loro bravi tag. Poi una tecnologia di elaborazione immagini di Microsoft Research, avanzatissima per l’epoca, le combinava in base ai tag riconoscendo gli elementi in comune tra le scene ritratte, tenendo in conto le prospettive diverse, e calcolando così lo scenario tridimensionale di cui facevano parte. Si trovavano sul sito stupendi pointclouds, nugoli di punti luminosi che formavano la gestalt 3D di un panorama o di un edificio, come la basilica di S. Marco a Venezia.
Questi modelli 3D erano navigabili nel browser e, cosa ancor più straordinaria, si poteva passare in ogni momento dal divisionismo della pointcloud alla visualizzazione fotografica, per esplorare la location attraverso le sue costituenti primarie: le migliaia di foto taggate “San Marco” o simile che tante persone avevano scattato nei loro viaggi, ognuna per conto suo, senza mai immaginare che stavano costruendo un’opera collaborativa. Le foto erano mostrate nella prospettiva giusta rispetto al viewpoint corrente nel browser, offrendo un’esperienza intermediale davvero unica.
Ma il primo servizio basato sugli user-defined tags che ricordo di aver usato è stato il comodissimo social bookmarking di del.icio.us, fondato nel 2003. Salvare i siti più interessanti nel mio profilo online invece che nella solitudine del mio browser, navigare i tag altrui scoprendo altri mondi, fu la mia prima vera esperienza di espansione orizzontale immediata della conoscenza, tipica della società dell’informazione. Quella che ora, mai incontrando una qualunque resistenza, è scivolata nel nostro normale disorientamento da information overload, un velo costante di nausea e di ansia da prestazione.
I tag user-defined si sono dimostrati gli index terms più adatti all’ecosistema informativo della rete globale, duttili abbastanza da adattarsi alla enorme varietà di sorgenti e di pratiche d’uso che si incontrano nel mondo. È la vittoria del particolare sull’universale aristotelico. Collegandosi tra loro, i tag possono comporre telai di grande complessità, che su grande scala si strutturano spontaneamente grazie alle proprietà statistiche dell’insieme. Tuttavia anche in contesti locali la loro modularità non gerarchica permette di creare grafi d’interesse, ad esempio operando sui dizionari idiomatici propri di un ambito del sapere o del lavoro.
È per questo che in Mnemonica abbiamo adottato i tag invece del file system gerarchico, quando ci siamo trovati davanti alla principale scelta di design: come organizzare i contenuti caricati. Nelle piattaforme di media asset management del settore di norma si ricalca lo schema classico del file system per organizzare le clip: un progetto contiene dei folder, ogni folder ospita dei contenuti, su ogni folder si possono fare certe operazioni (ad esempio l’invio a una serie di destinatari), sui file contenuti si possono fare altre operazioni. Queste piattaforme si ispirano al principio di abitudine: essendo il file system gerarchico così assolutamente familiare per tutti, dopo 30 anni abbondanti di home computing, è ciò che tutti si aspettano di trovare in un’interfaccia di gestione file, e tutti sanno come usarlo senza ulteriori istruzioni.
Ma anche qui l’universale non va necessariamente d’accordo col particolare. Era il file system la struttura informatica più adatta a chi lavora nella produzione cinematografica, considerando le loro specifiche modalità di lavoro, i tempi rapidi con cui devono accedere ai contenuti, il tipo di dati che generano, l’ordine in cui lo fanno e poi tornano a consultarli, il modo in cui interagiscono fra loro, e così via? La nostra risposta è stata negativa. A noi il file system, come del resto il folder stesso, sono sembrati arcaici e troppo rigidi rispetto alle esigenze quotidiane del cloud cinema. Quel modo fluido di lavorare seguendo un piano ma adattandosi continuamente alle circostanze meritava di essere assecondato da un’impalcatura altrettanto flessibile. E il giunto perfetto per costruirla era il tag.
Così abbiamo progettato il nostro flat indexing, che è una delle caratteristiche più speciali di Mnemonica.
Come funziona? Tanto per cominciare, i media sono ospitati in Screening Room che non sono folder ma ambienti di fruizione sociale controllata, fatti apposta per i requisiti della produzione film/tv. Sono ambienti attivi, nel senso che sono anche capaci di elaborare automaticamente i loro contenuti, ad esempio nell’applicazione dei watermark, e di distribuire contenuti a pubblici separati in tempi diversi.
Poi abbiamo i Day e i Bin, che sembrano contenitori o folder ma non sono né l’uno né l’altro. Sia i Day, i giorni di lavorazione, che i Bin, contenitori multi-purpose utilizzabili ad esempio come scene oppure come ruoli per il casting o locations, sono in realtà tag associati ai media. A questi si possono associare altri tag a piacere, mentre ai Bin si possono associare sia tag generici che tag contrassegnati semanticamente come location e character.
La semplicità con cui realizzano l’information retrieval, proprio grazie alla struttura a tag sottostante, è davvero unica. E qui dobbiamo osservare una cosa en passant: quando si crede che il file system sia la cosa migliore perché si può usare out-of-the-box, senza nulla da apprendere, si dimentica che c’è un altro caso in cui il manuale non serve: quando le cose si spiegano da sé mentre le usi. Così avviene in Memonica: quando tocchi un Day e lo vedi illuminarsi e al contempo vedi ridursi sia il media pool che la lista Bin accanto, e poi lo tocchi di nuovo e vedi tornare tutto come prima, capisci al volo che quel Day funziona come un filtro sul media pool che seleziona le sole clip che esso contiene. Come anticipato, però, “contiene” è solo una comoda metafora che aiuta efficacemente l’apprendimento della UI: la vera azione di un Day è selezionare un tag in un insieme di media.
Lo stesso vale per i Bin, il cui comportamento è del tutto analogo. E anche questa utilissima simmetria è possibile solo perché Day e Bin sono tag dei media e non sono annidati gerarchicamente, cosa che limiterebbe le possibilità. Sono entità di pari livello, collegate attraverso i media. Dunque per fare una playlist posso selezionare prima un qualunque Day, e poi una delle scene girate in quel Day; oppure, viceversa, posso selezionare prima una scena qualunque, e poi uno dei Day in cui è stata girata. Questa efficace immediatezza è ampliata e ulteriormente potenziata dal sistema combinato di tutti gli altri tag che gli utenti possono definire in Mnemonica, e che sono tutti filtrabili con i campi search disseminati ovunque nella UI.
Questo è secondo noi, e secondo i nostri utenti, il tipo di elasticità nell’ordinamento dei contenuti che meglio si addice alla gente di cinema. Because #welovefilmmakers.
[1] R.C. Daley (MIT), P.G. Neumann (Bell Labs), A General-Purpose File System For Secondary Storage
https://www.multicians.org/fjcc4.html